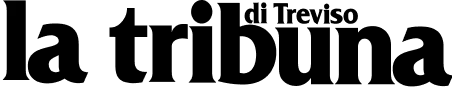Mario Martinelli: «La città come una classe, ogni singolo ha qualità da mettere in comune»
L’artista delle “ombre in rete” ricorda una Treviso vivace e ricca di gallerie. «Oggi non bisogna limitarsi a importare eventi ma piuttosto a generarli»

L’acqua, a Treviso, non è mai solo acqua. Riflette, moltiplica, trattiene memoria. È anche lungo questi corsi silenziosi che prendono forma le ombre di Mario Martinelli: figure leggere, che sembrano affiorare come presenze emerse dal fondo.
Non occupano lo spazio, lo ascoltano. Non chiedono attenzione, ma la meritano. Le sue ombre in rete non sono decorazioni urbane: sono dialoghi aperti tra luce e materia, tra ciò che passa e ciò che resta. Nascono dall’acqua e all’acqua sembrano tornare, come se la città, riflettendosi, avesse deciso di raccontarsi in controluce.
Sedersi accanto a Martinelli significa entrare in questo gioco di rimandi: tra visibile e invisibile, tra gesto artistico e vita quotidiana. A poche decine di metri dalla panchina c’è una delle sue ombre più note, la Bronsa. Non occupa lo spazio: lo abita.
Sta lì come una memoria che non chiede attenzione, ma che, se la incontri, ti costringe a rallentare. È anche per questo che Martinelli parla di ombre in rete: perché ogni figura è legata alle altre, alla città, alle persone che la attraversano.
«Mio padre è seduto lì»
Accanto a sé, su quella panchina, Mario oggi vorrebbe suo padre Giovanni, per tutti Nani. È a lui che pensa quando parla di ombre. Non come metafora artistica, ma come esperienza intima. «Nel mio giardino ho un muro bianco», racconta, «e lì mio padre è sempre seduto al suo tavolino. È l’immagine che ho di lui».
Giovanni era muratore. Un mestiere fatto di gesti precisi e silenziosi. Mario lo ricorda partire in bicicletta, con la borsetta e dentro gli strumenti essenziali: la martellina, il filo a piombo, la cazzuola. Tornava la sera, quando il figlio era già a letto. Il tempo condiviso era poco, ma solido.
«Io me lo ricordo nei giorni di festa», dice, seduto al tavolino, con davanti l’ombra del bicchiere di vino. In casa comandava la madre, ma il padre c’era. Presente. Non con le parole, ma con l’affetto.
Tra loro non c’è mai stata molta conversazione. Eppure il legame era fortissimo. Mario lo ha capito meglio dopo. «Gli ho fatto una foto quando aveva ottant’anni – dice - Alza appena la testa e mi guarda. Io quella foto ce l’ho nello studio. Dentro c’è tutto quello che ci siamo detti senza parlare».
Oggi Martinelli sente quell’ombra agire ancora dentro di sé. Un’eredità fatta di semplicità, di lavoro silenzioso, di una bravura mai esibita.«Era un uomo genuino, operoso. Non reclamava mai un ruolo. Eppure lo chiamavano maestro. Una volta il muratore bravo era il maestro: quello che sapeva fare bene il suo mestiere».
Il senso delle ombre
Se fosse seduto ora su quella panchina, accanto a lui, Mario non sa cosa direbbe a suo padre. «Sono cose che nascono guardandosi, sentendosi» dice a bassa voce. Forse è proprio questo il senso ultimo delle sue ombre: non spiegare, non occupare, non gridare. Ma restare. Come certe presenze che non hanno avuto bisogno di parole per lasciare un segno. Poi Mario Martinelli racconta la città partendo da sé. «Ho sempre vissuto Treviso – io campagnolo – come un’esperienza». Da bambino, ricorda, sua madre lo portava in bicicletta e a volte ci scappava anche un cioccolatino.
Poi arrivò il tempo del liceo Canova: «Andavo sempre in bici, ma con la giacca e la cravatta. I professori ci davano del “lei”. Eravamo tutti eleganti, anche in ricreazione, nel cortiletto stretto dal Sile che scorreva accanto». Una città sobria, nei colori e nei gesti. «Vestivamo grigio, marron. Il colore arrivò dopo».
Se ne accorse viaggiando in treno verso l’università, tra sciarpe gialle e maglioni rossi e blu: «Facevano festa. Era come se la città si stesse risvegliando». Allora non sapeva che quei fili colorati, spesso stessuti per difetto, prodotti in casa dai telai dei metalmezzadri evocati da Zanzotto, sarebbero diventati materia viva per le sue “tele stessute”: «Scarti preziosi, fili corpo e colore insieme».
Laboratorio Treviso
Treviso, in quegli anni, era un laboratorio aperto. «Le gallerie d’arte fiorivano». Piazza dei Signori, San Leonardo, Piazza Vittoria, la Pescheria: luoghi in cui l’arte era incontro quotidiano. «Non mancavo mai alle vernici - ricorda Martinelli - Si parlava, si discuteva, poi si continuava tutti a tavola, in osteria». La città, dice, «era il luogo delle belle esperienze, delle scoperte, degli incontri».
E le osterie erano parte essenziale di quell’urbanità. Alla Malvasia, da sior Enzo, «tra un bianchetto e mezzo uovo sodo con la cipollina, si tirava tardi a ciacolare». Quando non entrava più nessuno, l’oste abbassava la saracinesca e restava ad ascoltare quei ragazzi parlare di politica e di ragazze.
«All’uscita bisognava stare attenti a non cadere nell’acqua del canale che scorre subito fuori». L’acqua che ritorna, nei suoi ricordi, come un filo continuo.
Attraversata, non abitata
Oggi il suo sguardo è insieme affettuoso e inquieto. «La città era un formicolio di presenze vive. Ora tende a diventare come tutte: stesso centro storico, ristorazione alla buona, negozietti…».
Una città attraversata più che abitata. Anche l’arte, osserva, rischia di scivolare in un meccanismo consumistico: «Ci sono due turismi di massa: quello delle opere come merce e quello delle persone come consumatori». La sua visione è chiara: una città che non si limita a importare eventi, ma che li genera.
«Serve un piano di crescita, e poi chiedere ai privati di entrarci dentro». Eppure, il suo pensiero resta gentile. «Io penso che ognuno di noi sia energia che vuole lasciare traccia di sé. La città è l’accumulo stupendo di tutte queste tracce».
Nei suoi ricordi — e nelle sue convinzioni — oggi c’è soprattutto la forza che i ragazzi sanno sprigionare quando vengono messi nelle condizioni giuste. «Io ricordo bene l’energia dei giovani - dice - La forza dei loro bisogni di esprimersi, la potenza che tirano fuori quando fanno qualcosa che li riguarda davvero».
La classe
L’ha vista da vicino per trent’anni, insegnando Storia dell’arte al liceo artistico, a ragazzi tra i sedici e i diciotto anni. E l’ha vista soprattutto nel gruppo. Per Martinelli la classe non è mai stata una somma di individui, ma un organismo vivo. «Ho sempre usato la classe come gruppo di lavoro» racconta.
Non era «un’altra gioventù», dice. I tempi cambiano, certo, ma la sostanza no. Cambia semmai il ruolo dell’insegnante. «Se oggi insegnassi, sarei diverso da allora. Ma partirei comunque da loro».
Perché l’insegnante — secondo Martinelli — deve far sì che ognuno con la sua diversità trovi il suo ruolo nel gruppo che così si arricchisce con l’apporto di tutti. È una lezione che nasce dalla scuola, ma che per lui è auspicabile «anche in una città dove ognuno possa individuare e sviluppare le proprie qualità e poi essere chiamato a metterle al servizio del bene comune».
Alla fine tutto torna al punto di partenza: il gruppo, la relazione, la responsabilità condivisa. Come in una classe che funziona, anche la città — per Martinelli — cresce bene se ciascuno è messo in grado di trovare il proprio posto, sente di contare, e contribuisce a un disegno comune e a lasciarne il segno a quelli che verranno. Ecco la città.
Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso