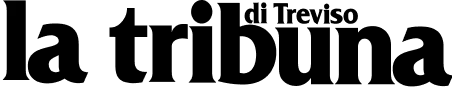Calcio, i 60 anni di Aldo Serena: «Nomade non per scelta,vi racconto la mia vita»

MONTEBELLUNA. Il tempo che passa ha la maglia numero 5. Sconti non ne fa. Aldo non si tira indietro, gli piacciono queste sfide: gomiti alti se serve, tacchettate a palla lontana da incassare e magari restituire, poi un bel gol di testa per far capire chi è il più forte. Figuriamoci se lo spaventa questo, di marcatore. «Paura di invecchiare? No, paura no. Mi piacerebbe, invecchiare». Tra pochi giorni, il 25 giugno, Aldo Serena compie sessant’anni. Ci ha ospitato nella sua casa di Mercato Vecchio, dove tutto è partito («da piccolo giocavo proprio lì», indica, «poi ho comprato il terreno») a sfogliare vecchie foto e spolverare ricordi di una carriera straordinaria: quattro scudetti (Juventus 1986, Inter 1989 da capocannoniere con 22 gol, Milan ’92 e ’93), una Coppa Intercontinentale (Juventus, 8 dicembre 1985), Coppa Uefa e Coppa Italia (Inter), due campionati vinti in B (Como e Milan).
Aldo, giochi ancora qualche partitella?
«No, il fisico non me lo permette più: anca e ginocchio mi tormentano. Il rapporto col mio fisico non è propriamente armonico: fino ai cinquant’anni ci conoscevamo, abbiamo fatto tante cose belle. Dai cinquanta in su lui sta andando da un’altra parte, non lo riconosco più. Non siamo più tanto amici».
Zenga, Tassotti, Baresi, Mozer, Brehme, Hermann, Littbarsky, Maradona, Careca, Serena, Völler. Questa online la si trova come la top-11 dei nati nel 1960.
«Beh, non male, ringrazio chi mi ci ha messo! Ce ne sono tanti di bravi e di bravissimi, alcuni anche simpatici, come Littbarsky: l’ho conosciuto grazie ai tedeschi dell’Inter. Ma chi ha fatto questa top-11?».
Un sito di fantacalcio. Ci giochi?
«No, non mi piacciono le cose virtuali, non mi appassionano».
Hai scelto la tua Montebelluna come casa, e non Milano, dove sei stato tanti anni.
«Decisione familiare, presa con mia moglie: vivevo molto bene a Milano, è una città che offre di tutto, soprattutto spettacoli e concerti. Però qui è un bel posto e abbiamo deciso di far crescere i figli un contesto più salutare, più sano. Giorgio ha 14 anni, Giulio 11: quando saranno grandi decideranno se preferiscono una grande città».
Che effetto ti fa pensare che abbattano San Siro?
«Un tuffo al cuore. Da piccolo non avevo mai visto San Siro, sono sempre stato tifoso dell’Inter ma tiepido, non scatenato: non ero di quelli che andavano allo stadio col papà, la mia famiglia aveva altre priorità, bisognava risparmiare e lavorare, anche sabato e domenica, sempre. Quando sono andato a giocare con l’Inter ricordo la prima volta che ho visto San Siro, una sera, prima di un’amichevole: mi sembrava un’astronave. Ecco, il film di Fellini, Amarcord, quando tutto il paese aspetta la nave dall’America: io ho visto una cosa del genere, San Siro con tutte le luci, le scale, la gente. Mi ha fatto innamorare, l’ho sempre sentito come casa mia, sportivamente. Abbandonarlo o abbatterlo mi sembra impossibile, lì c’è la storia».
Il tuo curriculum ha un sacco di squadre: perché non hai mai messo radici da qualche parte?
«L’Inter mi ha acquistato dal Montebelluna assieme al Como, poi mi ha riscattato e non ha mai voluto cedermi definitivamente, solo prestarmi: Bari, Milan, Torino, Juve... Solo nel 1991 mi è scaduto il contratto e sono andato al Milan a titolo definitivo. Io non l’avrei fatta una carriera così, per scelta, sarei uno fedele, che fatica a cambiare squadra e città».
Avresti sognato di fare la “bandiera” nell’Inter?
«Sì, all’Inter o altrove, anche al Milan in B dove ho pensato “finalmente sto trovando una squadra che mi apprezza”, o poi al Torino e alla Juve pure, ma poi sono sempre tornato indietro. Io non avrei fatto scelte così ma sono contento della mia carriera perché in un certo senso ho forzato la mia indole tranquilla e mi sono rimesso in gioco tutte le volte».
Il momento più alto della tua carriera? Lo scudetto da capocannoniere? L’Intercontinentale?
«Vincere la coppa intercontinentale con la Juventus mi ha proiettato su una dimensione internazionale. Sotto il profilo personale, però, l’aver vinto lo scudetto con l’Inter in quel modo, e da capocannoniere, contro avversari come il Napoli di Maradona e Careca, il Milan super di Sacchi, Van Basten e Gullit, mi ha dato molto: è stata l’affermazione con la maglia nerazzurra che non avevo mai avuto, il traguardo a cui aspiravo da sempre».
È stato Trapattoni l’uomo chiave della tua carriera?
«Ho avuto buoni rapporti con quasi tutti gli allenatori. Non ho mai avuto manager né procuratore: avrei guadagnato di più ma mi piaceva fare conoscenza di persona da subito. Devo dire grazie a tre allenatori. Gianni Rossi, che a Montebelluna mi ha portato in prima squadra a 17 anni, giocavo mezzala. Alla quinta di campionato, contro il Venezia, mi ha detto: facciamo fatica a fare gol, oggi giochi attaccante. Abbiamo vinto tre a zero, ho fatto due gol, e da lì sono diventato attaccante ed è cambiato tutto. Un altro grazie va a Gigi Radice: mi ha voluto all’Inter, poi ha fatto di tutto per portarmi con sé al Torino, nonostante l’Inter mi avesse già ceduto all’Udinese. Ho fatto arrabbiare Pellegrini ma sono andato, ed è stata la mia rampa di lancio: abbiamo rischiato di vincere lo scudetto, siamo arrivati secondi dietro il Verona. Sarei stato l’unico giocatore a vincere lo scudetto con quattro maglie diverse, siamo in cinque ad averlo fatto con tre. Poi Trapattoni, sì, che mi ha voluto alla Juventus e poi all’Inter. E devo dire un grazie anche a Bearzot: gli era rimasta una nostalgia del Triveneto e delle sue persone operose, e ha apprezzato il mio atteggiamento, non ero uno che aspettava la palla lì davanti, ero uno che lottava, non si tirava mai indietro».
Chi è oggi l’attaccante che ti somiglia di più?
«Oggi non saprei. Qualche anno fa forse Luca Toni per come difende palla, fa la boa... ma lui è cresciuto nel colpo di testa, prima non era bravo, io al contrario ho dovuto migliorare il resto».
Perché non hai mai pensato di fare l’allenatore? O ci hai pensato e non è andata?
«Sono stati gli incroci della vita. Quando stava finendo l’avventura di Trap all’Inter nel ’91 non era chiaro il mio futuro, e ho firmato un precontratto col Milan. Solo a fine stagione, Trapattoni mi ha chiesto di seguirlo di nuovo alla Juventus, “vieni con me e fai il mio uomo spogliatoio, non fai il titolare ma ho bisogno di te, poi inizi a fare l’allenatore”. Ma avevo già firmato col Milan. Da lì poi, con gli agganci in Fininvest, a fine carriera è nata la proposta di fare le telecronache con loro. Ho iniziato nel 1994 e continuo ancora».
Ti è rimasto il cruccio di non aver fatto l’allenatore?
«I primi anni ho staccato per scelta, ho viaggiato molto, dalla Patagonia all’India. Poi, passati i 40, mi era quasi venuta la voglia di fare l’allenatore, ma ormai ero comodo nel ruolo di vedere il calcio, la Champions... mi dava già soddisfazione e mi lasciava spazio per tante altre cose. Mi sono accomodato così, mi sono lasciato cullare dal benessere nella seconda parte della mia vita: nella prima ci ho dato dentro, ho lavorato in fabbrica con i miei e mio zio, dai 7 ai 18 anni faceva mattino a scuola, pomeriggio al lavoro e la sera a giocare a calcio».
Il Trap a 81 anni è su Instagram, tu con i social solo Twitter?
«Sì, parlo solo di calcio e cose che mi piacciono, come la natura. Non sono avvezzo alla modernità, sono pigro. Ora però, con i ragazzi piccoli che sono schegge, per non fare il “nonno” mi ci impegno».
Abbiamo parlato dei migliori allenatori. Rapporti difficili, invece?
«Con Marchioro, al Como. Sono arrivato dall’Inter, forse lui non mi aveva voluto, era salito dalla C e puntava sui “suoi”. Non riuscivo a ritagliarmi spazi, gli ho fatto un discorso chiaro: “ho 19 anni, non so ancora se posso fare il professionista e devo capirlo”. Avevo appena fatto la maturità, pensavo di iscrivermi all’università, volevo capire se fare il calciatore potesse essere la mia vita. Il Pisa mi voleva, con Marchioro siamo andati ai ferri corti e abbiamo litigato: non capivo perché volesse tenermi se non puntava su di me».
Hai pensato che quella potesse non essere la tua strada?
«Sì. Finita la stagione, avevo vent’anni, mi ha voluto Regalia al Bari, aveva stima di me. Era l’anno della svolta, ho pensato: vado, siamo in B, parto titolare, se non sfondo torno a casa, gioco in C, magari col Treviso, studio, faccio una vita diversa».
E invece.
«Invece al Bari è stata la consacrazione, quell’anno feci dieci gol e mi riprese l’Inter».
Questa quarantena senza calcio?
«Mi manca il brivido, quello che provo anche da commentatore entrando in stadi pieni, Camp Nou, Wembley, Anfield... sensazioni uniche, torno indietro nel tempo, ritrovo i brividi di una volta, l’adrenalina».
Giocare senza pubblico?
«L’ho fatto due volte, con la Juve, contro la Jeunesse e il Verona in Coppa campioni 1985/86. Non è calcio. Un gol nel vuoto non è lo stesso».
È vero che avete una chat su Whatsapp del gruppo di Italia 90?
«Sì, si chiama “Notti magiche”, l’ha creata Ferri un paio d’anni fa. Ci siamo quasi tutti, mancano Baggio e Ancelotti. Ciro Ferrara è uno dei più attivi, simpaticissimo. Si parla di calcio, ci si fanno gli auguri».
Gira una classifica online con i cento giocatori più “cattivi” della storia, e ti piazza al 97esimo posto.
«Beh, sono quasi fuori allora – ride – Ognuno fa il minestrone con quello che ha. Nelle prime cinque partite, al Monte in D, non riuscivo a fermarmi: ho rotto la mandibola a un portiere e il braccio a un altro. Ma non era cattiveria, dovevo giocare con quella foga: non avevo la classe di Van Basten o il dribbling di Altobelli. Le ho date e le ho prese: mi sono rotto la gamba, il menisco, setto nasale, sopracciglia, due lussazioni alla spalla...
Un po’ di tempo fa mi ha reso onore la tivù argentina mostrando il mio scontro con Oscar Ruggeri nella semifinale di Italia ’90, con la traduzione di tutte quelle che ci siamo detti, oltre che date: lui era uno dei massimi esponenti della scuola sudamericana di difensori, con un repertorio di colpi bassi, tacchettate sulle caviglie, intimidazioni. Sono entrato al posto di Vialli, mi ha accolto con un pugno sulla schiena. Non ho fatto una piega, e alla palla successiva gli ho dato io una gomitata. Allora lui mi è entrato da dietro, durissimo, e io ho cominciato a dirgli: non sento niente, sono di ferro, devi picchiare di più. A Mosca per i mondiali del 2018 l’ho incontrato, entrambi nel ruolo di commentatori: ci siamo abbracciati».
Partite più dure?
«I derby di Torino, più che quelli di Milano. Per il Toro l’acredine portava tensione, giocare con la maglia della Juve contro Corradini, Francini, Beruatto era dura. Quest’ultimo era un mio caro amico, vivevamo nello stesso palazzo, pranzavamo assieme, ma quando ci ho giocato contro nel 1985 ha iniziato a picchiarmi già prima di entrare in campo, dicendo “questo è solo l’inizio”. Pensavo scherzasse, ma aveva lo sguardo trasfigurato. Poi è finita 2-0 per noi, ho fatto gol, fortunoso, di petto».
Di quell’Italia-Argentina non parliamo, hai già raccontato altre volte il dolore di quel rigore sbagliato. Se potessi rigiocare una partita, esclusa quella, quale sarebbe?
«Eh, se fossi sicuro di poter segnare quel rigore o di far gol anche prima, non c’è altra partita che quella. Per le emozioni che vorrei rivivere, invece, l’esordio con l’Inter nel 1978: catapultato lì per gli l’indisponibilità contemporanea di Altobelli e Muraro, tutta la settimana in ritiro da solo col preparatore Onesti... Poi l’esordio, San Siro, contro la Lazio, mi fondeva la testa dalle emozioni, mi tremavano le gambe. Ma dagli spalti, prima di iniziare, ho sentito “Tonin! Tonin!”: erano i miei amici e compagni di fabbrica, mi chiamavano tutti così. Mi è venuta dentro una forza... Aldo, mi sono detto, sei uno “del Sasso”, come si dice a Montebelluna di quelli di Mercato Vecchio, di cosa hai paura? E poi ho segnato».
Per i gol sbagliati non dormivi la notte?
«Soffrivo eccome, faticavo a metabolizzare. Il culto familiare per il lavoro mi ha insegnato che le cose vanno fatte bene, sbagliare la cucitura di uno scarpone costa. Derby Toro-Juve, cross di Mauro, io arrivo sicuro di buttarla dentro ma un rimbalzo sul terreno ghiacciato mi fa ciccare la palla, me lo ricordo ancora. Dovevo arrivare con meno foga».
Platini il compagno più forte?
«Lui e Van Basten. Van Basten che tra l’altro, giocandoci contro in un derby, mi tirò una manciata di sabbia negli occhi prima di un angolo».
Ma è vero che i tedeschi dell’Inter avevano l’armadio con le birre in camera, e appena sei arrivato te le hanno offerte?
«Sì, si faceva attenzione a cibo e alcol ma non era così per tutti, questione di cultura. Tedeschi e inglesi non ci badavano. Anche Jordan, “lo Squalo”, al Milan si beveva due tre birre facili».
Con l’Argentina il ricordo più brutto. Il gol all’Uruguay in quel mondiale invece è quello più bello della carriera?
«Per le emozioni, senza dubbio. Tecnicamente, invece, un gol di tacco con la maglia della Juve, azione nata da una punizione scodellata da Platini. Alla Bettega».
CR7 o Messi?
«Messi ha avuto tanti regali dalla natura, Ronaldo no, per questo parteggio per lui: costanza, lavoro, fatica, fame, capacità di spostare l’asticella sempre più in alto. Ronaldo è straordinario, mentalità unica».
A chi voleva somigliare il giovane Serena? A Gigi Riva?
«Da piccolo, con l’onda sessantottina, mi piacevano quelli con i basettoni: George Best, Lele Oriali, Mick Channon».
Bravo dalla cintola in su, disse di te l’Avvocato.
«Lo disse a Villar Perosa, ero appena arrivato. Poi ho segnato cinque o sei gol in sei partite, e in un’intervista Agnelli ha detto che Platini era il giocatore che lo emozionava di più, ma io quello che lo aveva stupito maggiormente. È stata una soddisfazione enorme».
Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso