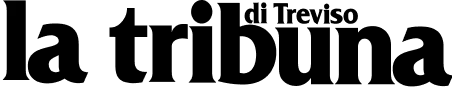Il racconto: «Io, fuori dalla Chiesa perché lesbica»

ODERZO. «Per la mia omosessualità ho dovuto restituire le “chiavi” del duomo di Oderzo. Non è stato un gesto fisico, bensì una ferita più profonda, che si è aperta con un rifiuto dopo un lungo percorso di fede in cui ho frequentato la parrocchia della mia città molto attivamente, dimostrandomi una buona cristiana».
Inizia così la storia di Marina Marzari, psicologa e psicoterapeuta opitergina di quarant'anni, oggi responsabile del coordinamento Lgbte di Treviso. Per capire il dolore che l'ha accompagnata dopo quel muro che si è alzato tra lei e la Chiesa, bisogna andare a ritroso, ai tempi in cui Marina partecipava alle attività dell'oratorio, alla messa domenicale, al coro, al gruppo scout, alla preparazione dell'altare per le funzioni. Anni in cui è vissuta e cresciuta in armonia con gli altri parrocchiani, guadagnandosi la fiducia del parroco e degli altri sacerdoti. «Fin da piccola sono stata molto legata alla religione e l'ho sempre coltivata in armonia, all'interno della mia comunità parrocchiale. Mi sono sempre sentita accolta e ho sempre cercato di dare il mio contributo» spiega Marina. Un rapporto di fede e collaborazione che a un certo punto si spezza, durante una confessione.
«All'epoca avevo 25 anni, ero ancora eterosessuale, ma mi ero fidanzata con un ragazzo separato» racconta «ho ritenuto di doverlo dire all'uomo di fede che avevo davanti. Sapevo che quella situazione non veniva contemplata dalla Chiesa, ma non mi aspettavo una risposta così brusca. Si è rifiutato di darmi l'assoluzione. È stato un trauma, mai avrei pensato che quella persona, con cui avevo un ottimo rapporto fino al giorno prima, mi trattasse in quel modo».
Da lì è cominciata per Marina una grande crisi personale e spirituale che si è tradotta, ben presto, in un allontanamento dalla Chiesa, più imposto che voluto. Una lontananza apparentemente incolmabile, che si è aggravata ancor di più al compimento dei trent’anni. «In quel frangente ho scoperto la mia omosessualità» ricorda «è stato un altro motivo di dolore per le regole che la Chiesa porta avanti impedendo la partecipazione ai sacramenti e alla comunione per chi è omosessuale».
Un altro ostacolo tra l'essere donna e l'essere credente. È allora che Marina ha cominciato la sua ricerca. Voleva colmare quel senso di smarrimento che la stava condizionando così tanto nel suo cammino di fede, non voleva dei nullaosta o delle giustificazioni, quanto la possibilità di trovare ascolto anziché giudizio. Decide allora di trascorrere un periodo nella comunità ecumenica del monastero di Bose, in Piemonte. «Dopo aver avuto solo porte chiuse da parte della Chiesa, lì ho ritrovato delle mani tese da parte di alcuni uomini di Chiesa» spiega «non si è trattato di compassione, ma di un dialogo diverso. Grazie a questo percorso, ora ho conquistato la “libera coscienza”e mi sono riavvicinata alla comunione. Sono consapevole che la posizione della Chiesa è diversa rispetto alla mia, ma sono riuscita a concedermi la possibilità di decidere autonomamente. Ho ripreso ad accostarmi a ricevere il corpo di Cristo prendendomi la responsabilità di quel gesto che la Chiesa mi negherebbe senza sé e senza ma».
Una negazione rispetto alla quale la giovane psicologa opitergina auspica un cambiamento più radicale. «Vorrei che si arrivasse presto a una maggiore omogeneità tra quello che la Chiesa dice nelle sue regole e quello che i sacerdoti devono applicare ogni giorno nel loro rapporto con le persone, con i fedeli. Se dipendesse da me lo tradurrei nel non fare differenze tra separati, divorziati e omosessuali se dietro a queste classificazioni c'è un percorso impegnato di fede. In fondo la trasgressione può anche non essere visibile, penso a un uomo sposato che va a messa tutte le domeniche e poi picchia la moglie». Parole che fanno eco, senza alcuna presunzione, a quanto Papa Francesco ha detto nel 2013: «Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?»
Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso