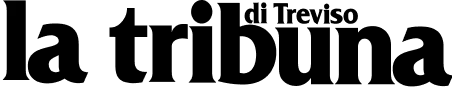Auvers, l’abbraccio senza fine dell’edera ai fratelli van Gogh

di MARCO GOLDIN
Si arriva fin qui, in una mattina fredda di gennaio. Sotto un cielo azzurro che è come una lastra che tutto sigilla. E niente può sfuggire della vita e del tempo. Si arriva da lontano, dopo una lunga strada, passando in mezzo a campi e colline bianchi di neve. E rami, e alberi che in quel cielo erano segni leggeri e profondi come vie segrete e silenziose. Diresti infinite. Si arriva da lontano, senza sapere. In mezzo al bianco della neve, su altopiani ondeggianti e d’incanto si aprono piccole valli e distese senza che nulla possa turbare il bianco della neve. Solo il bianco e la sua neve, niente di più pare esistere nel mondo.
Si arriva fin qui, in questa mattina di gennaio. E tutto è diverso da allora. Tu non puoi sentire il canto delle cicale, mentre guardi i campi attorno e sale una sfiatata foschia. E il verde degli alberi più lontani e il colore scuro della terra fatta di venti. E ancora, il bianco opaco del ghiaccio che ha serrato nella campagna l’acqua delle pozzanghere, dopo l’ultima pioggia. Strade di terra, e puoi sentire ancora il rumore dei passi. Quei passi, in un’estate che non torna.
Il 15 maggio del 1890, quasi fuggendo, lascia sul cavalletto a Saint-Rémy un quadro ancora fresco, che non può dunque portare con sé a Parigi. Prende un treno. Lascia sul cavalletto un’ultima immagine: una grande stella e una luna che brillano dentro un cielo del blu notturno, quasi elettrico, sopra un campo di grano, un carretto che passa, uomini che camminano in silenzio. E un cipresso che sale a un’altezza infinita. S‘infila nel cielo come una freccia.
Prende un treno e si ferma solo pochi giorni a Parigi, a salutare l’amato fratello Théo. Vedere per la prima volta il nipote che gli è nato, recando con sé un mandorlo in fiore che straccia con il suo bianco l’azzurro del cielo di Provenza. Viene come un profumo, di alberi che stanno sotto la linea delle sempre desiderate Alpilles. Lo porge con la mano. Resterà per sempre il segno di colui che sta per diventare l’assente. Un gesto di congedo. Come a dire: ti ho amato, vi ho amati, adesso prendo un’altra strada, ma ecco per voi il segno, ciò che avrete di me da ricordare. Ho pensato a quel bianco di mandorlo in fiore, mentre correvamo per venire qui, a Auvers, lungo il fiume Oise. Ho pensato a quel bianco quasi tempestato di pietre preziose, mentre si poteva vedere a ogni svolta della campagna il bianco screziato della neve. Il bianco che circonfonde, si prende cura, copre ogni male, fa di ogni cosa un grande silenzio, mentre vengono nell’ora del tramonto luci come del grande Nord. E il disco immenso del sole sparge del suo colore tutta la terra, in un sussulto che risuona piano. Perché tutto è solo silenzio. Il bianco, la purezza di chi parte verso il lontano, il desiderio che quella purezza rimanga a chi non parte e resta sulla riva a salutare. Ho pensato a tutto questo, mentre mi preparavo all’incontro.
Si entra nel piccolo paese, si sceglie la strada in mezzo a case con i tetti spioventi. Si sceglie o si viene portati, condotti da una forza leggera, la forza dello spirito che ritorna. Si lascia un’ultima casa e si sale sotto ad alberi dalle chiome adesso rade. Su un sentiero stretto, la terra gelata. Fino al punto in cui s’incontra una croce di legno, consumata dal tempo, dalle nebbie, dalle nevi, dalle piogge, dal sole. Lì, proprio in quel punto, la campagna si apre e il sentiero prosegue dritto. Il sentiero passa giusto in mezzo a grandi prati ugualmente verdissimi in gennaio, e campi che attendono il grano che crescerà.
Sulla sinistra, in fondo, file di alberi e rare case nel mezzo della campagna, mentre una foschia lievissima s’insinua fra tronco e tronco, leggera, appena respirata. E’ una danza quasi immobile nei secoli. E sulla destra, altri alberi, fino al punto in cui tra i rami si vede la torre della chiesa di Auvers, l’abside antica. Pietre gialle e un suono di campane a chiamare. Ci sarà la gente del piccolo paese che va. Davanti a me, distanti, camminano Ketty e Maddalena. Mi anticipano nei passi, guardano su in cima fino alla linea dell’orizzonte. Ognuno preso nei suoi pensieri, ognuno avvinto a questa forza che sentiamo ci sospinge. Uno spirito. In fondo, ancora più lontano, il bianco del muro di un cimitero. Solitario, al centro dello spazio, in questa mattina di gennaio. In questa mattina della nostra vita.
Si entra. Siamo arrivati fin qui. Anche lui era arrivato qui, il 20 maggio del 1890. Salito su un altro treno, poco tempo per giungere. L’azione del giungere, lui già quasi spirito, ma ancora tutto pieno di un’umanità sofferta. Grondante. Di occhi, di sguardi. Ah, i suoi occhi verdi come uno stagno fiorito a primavera. Lui infine giunto a Auvers, dopo avere lasciato il fratello a Parigi. Quadri in preda a una febbre, quasi uno al giorno per settanta giorni. I cieli, le piogge, i campi, il grano, i corvi che vi passavano sopra, la gente del posto, la chiesa, il Municipio, il castello, il dottor Gachet e la figlia seduta intenta al pianoforte. Un vestito lungo tutto tempestato del bianco di una tarda fioritura di giugno. Aveva dipinto per sopravvivere, per sopravvivere aveva dipinto. Si era infilato nei giorni ancora, tutto preso da quella bellezza che è stata come un tuono per sempre protratto. Un rombo scavato nel tempo. Irredento, irredimibile.
Siamo arrivati fin qui. Viene quasi da piangere. Si vedono le due lastre tombali, solo i nomi di Vincent e Théo, andati via a pochi mesi l’uno dall’altro, fratelli per sempre, anche nella morte. Il primo nel caldo opprimente di luglio, il secondo proprio in questa stagione, nel freddo del principio dell’anno. Solo i nomi e i numeri del loro passaggio nel tempo. Si vedono le due lastre tombali, i nomi incisi che qualcuno ha rinfrescato di recente. Si vedono così, alla fine di un piccolo mare d’edera che il figlio del dottor Gachet piantò davanti alle loro tombe quando anni dopo vennero messi vicini. Un solo mare d’edera, per tenerli in un abbraccio senza fine. E abbiamo portato due lumini, e li abbiamo accesi e posati. Adesso le fiammelle resistono senza spegnersi dentro questo piccolo soffio di vento.
E dietro le lastre tombali, il muro povero di pietra grigia. E dietro il muro, la campagna infinita. E sopra ogni cosa, anche oggi, il cielo azzurro. Vincent van Gogh ha camminato su queste strade di terra, sotto questo stesso cielo azzurro. Non si riesce proprio a venir via, lo sguardo che torna sempre su quell’edera, su quella pietra con il nome inciso. Sembra impossibile, ma è stato così. Ha camminato qui, su queste strade di terra. E viene quasi da piangere. (12)
Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso