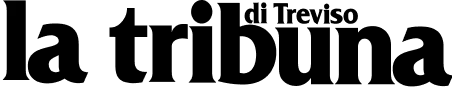"Le camere a gas? Io c'ero, io le ho viste"
«Lo dica lei, a quelli che sostengono che le camere a gas non esistono, di venire da me, che gli racconto come stavano le cose». Albina Moimas, 88 anni, friulana d’origine e trevigiana d’adozione, è stata deportata ad Auschwitz quando aveva 22 anni. Vi è rimasta 4 mesi, prima di essere trasferita a Wittemberg, a lavorare nelle industrie tedesche. Albina non era né ebrea né partigiana, ma solo zia di un partigiano. Ha vissuto sulla propria pelle l’orrore del lager e ha visto la sofferenza di chi le stava attorno. «Le camere a gas non servivano solo a disinfettare», testimonia.

2009 , CAMERE A GAS? PER DISINFETTARE. Don Floriano Abrahamowicz, capo della comunita' lefebvriana del Nordest, in un'immagine di repertorio. ''Io so che le camere a gas sono esistite almeno per disinfettare, ma non so dire se abbiano fatto morti oppure no, perche' non ho approfondito la questione''. Lo dice don Floriano Abrahamowicz in un'intervista alla Tribuna di Treviso. ''Tutta questa polemica sulle esternazioni di monsignor Williamson riguardo l'esistenza delle camere a gas - afferma il sacerdote tradizionalista - e' una potentissima strumentalizzazione in funzione anti-Vaticano". Secondo il presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, i preti che negano l'Olocausto dovrebbero togliersi l'abito talare. DAVIDE BOLZONI / ANSA / DC
«Ci sono tante, troppe cose da raccontare», dice Albina, che vive a Treviso dal ’50, dopo aver sposato Angelo, un militare dell’aeronautica di Istrana. Al momento del rastrellamento di trovava a Ronchi dei Legionari, suo paese natale.
Signora Albina, vuole raccontarci cos’è successo nel’44?
«Mi hanno portato via il primo giugno di quell’anno, per un nipote che era partigiano. Con me c’erano sua mamma, cioè mia sorella, mio cognato e altri due conoscenti che erano con loro. Io ero scesa in piazza a Ronchi perché mia sorella era stata rastrellata. Le portavo una valigia. Quando sono arrivata, sul camion hanno caricato anche me. Eravamo in tanti, tutti deportati politici. Ci hanno portato Trieste, e abbiamo fatto un mese di carcere al Coroneo prima di portarci ad Auschwitz. In Germania siamo arrivati dopo cinque giorni di viaggio in treno. Non erano treni normali, eravamo stipati come bestiame nei vagoni, senza darci da mangiare. Per fortuna, prima di partire per Trieste, alcuni miei conoscenti, che avevano saputo della nostra partenza per la Germania, mi hanno portato delle ciliegie e un salame. Ho spartito tutto con quelli che erano in vagone con me. Quella era la stagione delle ciliegie. A casa avevamo gli alberi di ciliegio».
Cosa ha visto appena arrivata nel campo?
«Auschwitz era enorme, pieno di gente. Da una parte c’erano gli uomini e dall’altra le donne. Tantissimi ebrei. Siamo entrati con il treno. Lì ci hanno fermato per alcuni minuti e nel mentre è arrivato un treno di ebrei. Hanno aperto le porte di questo treno e i tedeschi hanno cominciato a buttare per terra, prendendoli per braccia e gambe, quelli che erano morti nel viaggio. E’ la prima scena che abbiamo visto quando siamo arrivati. Dopo ci hanno fatto scendere e mettere in fila. C’era tanta gente, magra, con i capelli rasati. Ci guardavano e noi guardavamo loro e lì è cominciato tutto».
Ci racconti...
«Hanno separato uomini e donne. Ho rivisto mio cognato solo quando sono tornata a casa, a Ronchi. Aveva la tubercolosi ed è morto dopo poco tempo. A noi donne hanno fatto la doccia, e ci hanno lasciate ad asciugare nude al freddo. Poi ci hanno tatuato il numero. Il mio lo porto ancora impresso nel braccio: 82139. Quella è stata l’ultima volta che ho visto mia sorella perché poi ci hanno divise fra donne adulte, mia sorella aveva 42 anni, e donne più giovani. Mia sorella non è più tornata a casa».
Che cosa è successo poi?
«Mi hanno portato in inquarantena dentro la “baracca” numero 13, perché dicevano che portavamo malattie. Non ci siamo quasi mai lavate in quel periodo. Io ero piena di pidocchi. Ci alzavamo verso le 5 e le donne delle Ss, con i cani enormi, facevano l’appello e per un’ora stavamo praticamente nude al freddo, alla pioggia. C’erano tante donne ebree, ma non ho stretto legame con nessuna di loro. Non c’erano legami di amicizia con nessuno lì dentro. Eravamo perse e basta. L’unico pensiero era “chissà se arriverò mai a casa”. Dopo la quarantena hanno cominciato a metterci nei blocchi, dormivamo nei letti con la coperta e senza materassi. Poi ci hanno portato nei campi a lavorare la terra, a raccogliere fagioli e frumento. Quando andavamo a lavorare, sul grande portone c’erano delle signorine vestite a modo che con il violino e altri strumenti, suonavano quando passavamo. Era agghiacciante. Quando lavoravamo, se non eravamo veloci, i tedeschi ci davano dei colpi tremendi. Ma più delle botte, mi hanno ferito le umiliazioni continue che ricevevamo: il taglio di capelli, l’essere messe nude. Non eravamo più noi, non ci riconoscevamo più. Questo fino a ottobre del ’44. Poi ci hanno trasferito a Wittemberg vicino Berlino, a lavorare nelle industrie, perché ad Auschwitz non c’era più tanto lavoro».
Riguardo Auschwitz e i campi di concentramento, lo sa che in questi giorni ci sono stati dei preti lefebvriani che hanno messo in dubbio l’esistenza delle camere a gas? Uno di loro ha detto che sono esistite «almeno per disinfettare»...
Dica a questi preti che vengano da me che racconto loro se esistevano o no le camere a gas. E non servivano solo per disinfettare. Noi in quelle stanze facevamo la doccia, le ebree entravano e non ne venivano più fuori. E c’erano cumuli di cadaveri che venivano bruciati nei forni crematori. Ma accanto ai morti ce n’erano anche altri, di vivi. La mattina, noi ragazze andavamo nei campi a lavorare intorno a Birkenau. Un giorno da lontano abbiamo visto una fila di 100 altre ragazze, che avranno avuto sì e no 16 anni, nude, senza capelli con le coperte sulle spalle. Dopo poco abbiamo cominciato a vedere il fumo e a sentire un odore insopportabile. Quelle ragazze sono tutte morte».
Riproduzione riservata © Tribuna di Treviso
Leggi anche
Video